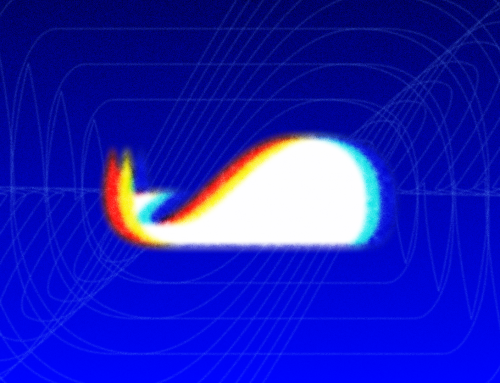Una rete fatta di persone
I casi esaminati nei primi due capitoli di Mind the Challenge porterebbero a pensare che i social network (e più in generale l’infrastruttura che ne permette l’esistenza, ovvero Internet) siano strumenti in grado di promuovere solo ed esclusivamente comportamenti negativi. La disinformazione sistematica, la manipolazione psicologica e i rischi per la salute dei minori sono tuttavia fenomeni molto rilevanti anche nelle nostre vite offline e il principale apporto della tecnologia, in questo senso, consiste semmai nell’esposizione potenzialmente illimitata offerta dalla Rete, che si ripercuote inevitabilmente sui fenomeni emulativi analizzati nel capitolo 2.
Questo non vuol dire che i social network siano strumenti neutri – come del resto spiegava il sociologo canadese Marshall McLuhan a metà degli anni Sessanta, che coniando l’espressione «il medium è il messaggio» identificò i media con il loro modo di strutturare la comunicazione – ma semplicemente che le intenzioni del singolo utente sono cruciali nella definizione delle sue azioni comunicative, ben più della piattaforma utilizzata per veicolarle. E se gli utenti, in quanto esseri umani, possono sfruttare le potenzialità di Internet per elaborare pericolose sfide e subdoli contenuti mistificatori, gli stessi strumenti digitali possono diventare un prezioso alleato in cause ben più nobili.
Allontanandoci per un momento dal tema delle challenge online, è quanto accaduto, ad esempio, durante la cosiddetta “Primavera Araba”, la serie di proteste e mobilitazioni che tra il 2010 e il 2011 sconvolsero alcune regioni del Medio Oriente e del Nord Africa, rivoluzionando la situazione geopolitica dell’area al punto da portare alla destituzione dei regimi autoritari di Libia, Tunisia ed Egitto. Per molto tempo quei governi avevano soffocato il dissenso attraverso una sistematica repressione della libertà di stampa e di associazione, ma non erano preparati ad affrontare la minaccia di chi, all’alba degli anni Dieci del Duemila, era finalmente in grado di aggirare la censura dell’informazione attraverso Twitter e di darsi appuntamento in piazza creando un semplice evento su Facebook.
Uno degli episodi più significativi di quelle proteste fu originato proprio sui social media e, come raccontato da un articolo del New York Times, vide protagonista l’allora ventinovenne Wael Ghonim, un dipendente di Google che l’8 giugno 2010 si imbatté su Facebook nella foto del corpo sfigurato di Khaled Mohamed Said, un suo coetaneo fermato dalla polizia egiziana in un Internet café e poi pestato a morte. Mosso dalla rabbia verso quell’ingiustizia, Ghonim creò la pagina Facebook Kullena Khaled Said (in italiano, “Siamo tutti Khaled Said”), che nel giro di appena tre mesi raggiunse quota 250 mila follower e portò all’organizzazione di “proteste silenziose” nelle principali città egiziane. Una di quelle proteste andò in scena il 25 gennaio 2011 a piazza Tahrir, al Cairo, ed è ancora oggi riconosciuta come la scintilla che infiammò la sollevazione del popolo egiziano e avviò la catena di eventi che portò alle dimissioni del presidente Hosni Mubarak.
Da quel momento in poi, il ruolo di Internet nella definizione delle identità politiche e nelle dinamiche di attivismo dal basso è diventato oggetto di costante riflessione accademica, anche perché nel decennio successivo le piattaforme digitali avrebbero dato vita a numerose esperienze di aggregazione: basti pensare al Movimento 5 Stelle in Italia, al Movimento 15-M in Spagna e alle parentesi americane di Occupy Wall Street e all’alt-right americana a sostegno di Donald Trump. La Rete è insomma diventata in grado di avere conseguenze estremamente reali, oggetto di dibattito nell’opinione pubblica e potenzialmente in grado di rovesciare governi e di eleggerne di nuovi.
Tutto questo fermento non è certo passato inosservato agli occhi delle piattaforme che, ormai diventate a tutti gli effetti dei veri e propri attori sociali, hanno compreso l’importanza della propria funzione storica e di una comunicazione all’altezza delle nuove responsabilità, decidendo di puntare molto sulla solidarietà.
Il nuovo volto dei social network
Il 15 dicembre 2013 Facebook ha lanciato così un tasto “Dona ora”, con il quale gli utenti potevano scegliere di destinare le proprie donazioni ad alcuni enti benefici selezionati dall’azienda di Palo Alto (19 in tutto, inizialmente, tra i quali Croce Rossa Internazionale, Unicef e Wwf). Ma questo è stato solo il primo passo verso la creazione di un vero e proprio strumento per la raccolta fondi, introdotto da Facebook nel 2015 e che nel giro di un anno è riuscito a coinvolgere oltre 750 mila organizzazioni non-profit.
Entro la fine dell’anno 2016, la società fondata da Mark Zuckerberg era riuscita nell’impresa di costruire un piccolo universo solidale, composto da strumenti per la donazione del cibo, da partnership filantropiche di alto profilo (una su tutte, quella con la Bill & Melinda Gates Foundation) e dal nuovo arrivato nell’universo Facebook, la notifica “Safety check” per fornire notizie sul proprio stato di salute nel corso di catastrofi naturali o atti terroristici. Nel 2017 Facebook ha definitivamente eliminato la sua tassa del 5 per cento sulle transazioni benefiche, annunciando al contempo un programma per stimolare donazioni a disposizione degli utenti nel giorno del proprio compleanno (alle quali la società partecipa, ancora oggi, aggiungendo un contributo di 5 euro per utente).
Tutti questi sforzi (estesi nel 2019 anche a Instagram, l’altra piattaforma di casa Meta) hanno contribuito a raccogliere l’impressionante cifra di 5 miliardi di dollari in 5 anni – 2 miliardi solo dall’inizio della pandemia a oggi – donati da una platea complessiva di 85 milioni di utenti. Numeri che hanno reso Facebook uno dei player emergenti nel mercato del crowdfunding mondiale e che permettono alla società, d’altra parte, di incassare lauti emolumenti dalle principali Ong in cambio di sponsorizzazioni e annunci pubblicitari.
Una beneficenza non del tutto disinteressata, insomma, ma che ha caratterizzato gran parte dell’evoluzione dei moderni social network e che racconta meglio di qualunque dato come Internet non sia caratterizzato da dinamiche esclusivamente negative. Questo è il pezzo della storia che riguarda le sole piattaforme digitali, quella porzione di solidarietà stimolata dall’alto e perseguita attraverso l’attivazione di strumenti pensati per collegare gli utenti alle organizzazioni non-profit.
Come detto in precedenza, però, le piattaforme sono soprattutto la somma delle persone che le abitano e le iniziative di solidarietà lanciate dagli utenti dei social network in questi anni meritano un capitolo a parte.
Quando le challenge fanno bene
Internet (e i social network) non sono dunque un luogo solo negativo, ma anche positivo e stimolante. Prima di entrare nel vivo del nostro racconto e scoprire quali sono le challenge positive che hanno coinvolto milioni di utenti negli ultimi anni, lasciamo brevemente la parola a Letizia Atti, pedagogista ed educatrice digitale, che ci spiega quali sono i vantaggi che Internet offre oggi ai giovani.
Oltre al ruolo di Internet come palestra per conoscere sé stessi e mettersi alla prova, diversi studi concordano nel ritenere la conoscenza delle nuove tecnologie e la capacità di saperle sfruttare al meglio un aspetto centrale nella crescita delle nuove generazioni, che devono sempre più stabilire con il mondo online un rapporto consapevole ed essere in grado di sfruttarne i benefici. Proprio nell’ottica di un futuro sempre più digitale e pensando agli adolescenti, perché Internet è (anche) un bene? Ce lo spiega Atti.
Dunque, Internet e i social network – se utilizzati correttamente – possono essere uno strumento per i giovani per mettersi alla prova, svolgendo un ruolo importante nel rapporto con sé stessi e con gli altri: il desiderio di sfida che naturalmente accompagna la crescita degli adolescenti non deve quindi essere interpretato solo negativamente poiché, se declinato positivamente, è una reale occasione di crescita e conoscenza. Come ricordato da Atti, dunque, la sfida non è di per sé pericolosa, ma lo diventa se declinata nel modo sbagliato.
E proprio in questo contesto, che ruolo rivestono le challenge positive?
Come notato da Atti, rientrano nella categoria delle challenge positive quelle benefiche, finalizzate ad una raccolta fondi o quelle che, più in generale, puntano a sensibilizzare l’opinione pubblica su un dato tema. Della Ice bucket challenge, nominata da Atti e probabilmente conosciuta da molti, parleremo tra poco. Prima passiamo in rassegna qualche esempio di challenge positiva, così da renderci conto della portata e delle declinazioni del fenomeno. E partiamo proprio dalla Trash challenge, altro esempio fatto da Atti.
Nata nel 2015, la Trash challenge (trash in inglese significa spazzatura) è direttamente collegata ad un’iniziativa che ha a che vedere con un’azienda di nome Uco: stiamo parlando del progetto #TrashTag, nato da un’idea di Steven Reinhold, al tempo responsabile del marchio. Mentre Reinhold era in viaggio in California con un amico, uno scontrino è volato fuori dal finestrino e da lì ha preso vita il desiderio di raccogliere durante il viaggio almeno cento oggetti-spazzatura trovati lungo il percorso, immortalare con uno scatto il momento, pubblicare sui social la fotografia accompagnata dall’hashtag #TrashTag, e promuovere così la pulizia dell’ambiente e l’attenzione verso la raccolta differenziata.
L’iniziativa si è poi trasformata in una vera e propria challenge indirizzata agli adolescenti nel 2019, quando è sbarcata su Facebook come provocazione verso i giovanissimi e che ha avuto un inaspettato successo, superando le 337 mila condivisioni e portando alla nascita di fenomeno non solo social, ma anche educativo e incentrato sul rispetto per il nostro Pianeta. Nel corso degli anni i social network si sono popolati di fotografie di spiagge, parchi, strade e luoghi pubblici ripuliti dai giovani che li frequentano.
Can your team everrrrrrrrrrrrr???😘
And yes, that’s us striking the #WorldWithoutWaste pose. We went to Kuje, we saw & we conquered.#ProudTrashHater#KujeCleanUp#TrashChallenge#InnovativeVolunteerism#TrashFreeNigeria#AbujaTwitterCommunity pic.twitter.com/ZoHZoTPSeB
— Adesuwa Obasuyi (@adesuwagreen) May 4, 2019
Rientra poi tra le challenge positive anche la Mannequin challenge, nata con l’intento di divertire immortalando una o più persone immobilizzate nell’atto di compiere dei gesti di vita quotidiana, e diventata poi anche uno strumento di denuncia quando a novembre 2016 l’attrice Simone Shepherd ha pubblicato sul proprio profilo Instagram un video che, realizzato rispettando le regole della challenge, mirava a sensibilizzare l’opinione pubblica sul movimento Black Lives Matter. Non solo: grazie alla challenge si è anche parlato positivamente del lavoro di squadra e dell’importanza dei rapporti con gli altri (la presenza di almeno due persone è necessaria per la realizzazione stessa dei filmati). Sotto questo punto di vista, aveva fatto notizia la scelta di un famoso programma televisivo filippino, It’s Showtime, di partecipare alla challenge coinvolgendo tutti i presenti, pubblico compreso.
Altri esempi di challenge che rientrano tra quelle che fanno bene a sé stessi e agli altri, è la 100 Happy days (o la versione ridotta 7 Days Gratitude challenge): come intuibile dai nomi, la sfida prevede che si condivida sui propri profili social immagini di ciò che giornalmente contribuisce a rendere felice l’utente che partecipa al gioco. Challenge di questo tipo hanno un effetto positivo sull’umore delle persone. In questo nostro elenco riassuntivo (ma non esaustivo, le challenge sono davvero tantissime!) rientrano anche le challenge che riguardano direttamente i nostri amici a quattro zampe: la Snoot challenge, dove snoot significa naso, prevedeva che i padroni pubblicassero video o foto del del naso dei propri cani racchiuso all’interno di cerchi formati con le mani. Oltre che divertente, il gesto è anche utile per abituare gli animali ad indossare una museruola o particolari collari post-operazione.
Giocare con sé stessi e mettere alla prova gli altri
Le challenge positive non sono poi solamente quelle che prevedono dei finanziamenti destinati a nobili cause o l’impegno per un comune ideale: rientrano in questa categoria anche le innumerevoli challenge che invitano a mettersi alla prova con balletti, singoli o di gruppo. Qui gli esempi sono numerosissimi, dalla Renegade Dance al Ballo della felpa. Ma non solo: le challenge “danzanti” hanno anche finito per coinvolgere interi nuclei familiari, come nel caso della Blinding lights challenge, sfida che invitava a ballare con i propri genitori o nonni.
Come abbiamo poi visto nel primo capitolo, le challenge si distinguono da altri contenuti presenti su Internet perché invitano l’utente a compiere un’azione, spesso vicinissima alle abitudini quotidiane: tra queste, c’è anche cucinare. Le challenge culinarie sono un vero e proprio genere e le sfide possono essere di vario tipo: dalla Hot chocolate bomb challenge con cui gli utenti si sono sfidati in una golosa (e calorica!) ricetta a base di cioccolato, alla Lemon face challenge dove gli utenti si immortalavano mentre mangiavano una fetta limone per supportare la lotta contro un tumore infantile al cervello.
Dunque, le challenge positive (e innocue) che si sono diffuse negli anni sono numerose e in tutti i casi i partecipanti sono stati invitati a fare qualcosa (pulire, giocare, cucinare) o a non fare niente (stando immobili come manichini). C’è poi almeno un caso in cui il vero successo della challenge non è stata la sua viralità e nemmeno l’azione immortalata dal video, ma il raggiungimento di un traguardo ben più ambizioso: è il caso dell’Ice bucket challenge.
Il caso Ice Bucket challenge
L’esempio finora più famoso di social challenge positiva è quello dell’Ice bucket challenge. La sfida, a scopo benefico, era stata lanciata nell’estate del 2014 negli Stati Uniti d’America, diventando presto virale in tutto il mondo con il coinvolgimento di tantissime persone: semplici cittadini, cantanti, attori, sportivi, politici e altri personaggi famosi.
Ma come funzionava la challenge? In modo molto semplice: gli utenti pubblicavano sui propri profili social dei video accompagnati dall’hashtag #IceBucketChallenge. I filmati immortalavano l’utente mentre si versava in testa un secchio di acqua gelata e successivamente invitare, nominandole, altre persone a partecipare alla sfida entro 24 ore. Lo scopo era quello di raccogliere fondi per la sclerosi laterale amiotrofica (Sla), contribuendo a finanziare la ricerca scientifica. La Sla è una patologia rara, dovuta a un processo atrofico che colpisce elementi del sistema della motilità volontaria provocando una paralisi muscolare progressiva che coinvolge la capacità di muoversi, di parlare, di deglutire e di respirare.
Dopo aver pubblicato il video sui propri profili social, ogni utente americano poteva scegliere di donare una qualsiasi somma alla Als Association, organizzazione statunitense no profit nata nel 1985 e impegnata nella ricerca sulla Sla; con la viralità e diffusione della challenge anche al di fuori degli Stati Uniti, gli enti coinvolti nelle donazioni sono poi stati diversi, come vedremo tra poco. Secondo uno studio della Johns Hopkins University, la challenge ha complessivamente permesso la raccolta di oltre 220 milioni di dollari in tutto il mondo, contribuendo direttamente all’arricchimento dei fondi destinati alla ricerca e al progresso scientifico.
È interessante capire come questa campagna di sensibilizzazione è nata e quali sono state le dinamiche che l’hanno portata ad avere tale successo. Come ricostruito da Time, all’inizio la challenge non aveva nulla a che fare con la raccolta fondi per la ricerca sulla Sla. A luglio del 2014 «Chris Kennedy, un giocatore di golf di Sarasota, in Florida, viene nominato da un amico per partecipare all’Ice Bucket Challenge. La campagna non era legata a nessuna organizzazione di beneficenza e i partecipanti ne dovevano scegliere una per effettuare le donazioni. L’amico di Kennedy aveva selezionato ad esempio un ente che si occupava di un bambino della zona malato di cancro». Ma è a partire da Kennedy che la challenge viene collegata per la prima volta alla Sla: l’uomo infatti nel suo video pone l’attenzione sulla malattia nominando la cugina di sua moglie Jeanette Senerchia, il cui marito Anthony è affetto da Sla. A sua volta Senerchia accetta la sfida: pubblica il video con il secchiello di acqua gelata sul suo profilo Facebook e nomina altre persone. La sfida, collegata da Kennedy alla Sla, inizia così a diffondersi a macchia d’olio fino a raggiungere Pat Quinn, un uomo con la Sla di Yonkers, comune situato nello Stato di New York. A sua volta, tramite Quinn, la sfida arriva a Pete Frates, ex capitano della squadra di baseball del Boston College, a cui nel 2021, all’età di 27 anni, era stata diagnosticata la Sla.
È con Frates che la challenge ottiene attenzione nazionale. Dopo la pubblicazione il 31 luglio 2014 del video di Frates sul suo profilo Facebook, la campagna decolla e diventa virale. L’ex sportivo, che all’epoca viveva a Boston e che morirà nel 2019 a 34 anni a causa della malattia, ha una grande rete di sostenitori ed è anche impegnato all’interno della comunità di persone affette da Sla. Come spiegato in un articolo della National Public Radio (Npr), Frates in questa sfida social coinvolge partecipanti di alto profilo, come la star dei New England Patriots Tom Brady e il proprietario dei Red Sox John Henry: «In poco tempo, celebrità come George W. Bush, Oprah Winfrey, Lady Gaga, Bill Gates e Steven Spielberg pubblicano i propri video dell’Ice Bucket Challenge». «Quello che è iniziato come un piccolo gesto per far fare un sorriso ad Anthony e portare un po’ di consapevolezza su questa terribile malattia si è trasformato in un fenomeno nazionale ed è qualcosa che non avremmo mai potuto sognare», ha dichiarato Chris Kennedy in un’intervista.
Dagli Stati Uniti la sfida si è poi diffusa via social in tutto il mondo: Australia, Nuova Zelanda, Canada, Messico, Brasile, Germania, Filippine, Porto Rico, India e Italia. Secondo i dati forniti da Facebook a settembre 2014, tra il 1° giugno e il 1° settembre sono stati condivisi sul social oltre 17 milioni di video a tema Ice bucket challenge, visualizzati più di 10 miliardi di volte da oltre 440 milioni di persone. Su Instagram, nello stesso periodo, sono stati caricati 3,7 milioni di video con gli hashtag #ALSicebucketchallenge e #icebucketchallenge. Quello del cantante pop Justin Bieber è stato il più popolare. Anche su Youtube la challenge ha avuto una grande attenzione: i contenuti a tema Ice bucket challenge sono stati visti complessivamente più di 43,5 milioni di volte, con 24.357 video diversi caricati sulla piattaforma. Nel 2014 l’Ice bucket challenge è risultato su Google tra i termini più ricercati a livello globale.
Il successo online e il successo scientifico
La diffusione a livello globale ha avuto un forte impatto economico anche sulle donazioni agli enti che si occupano di ricerca sulla Sla. All’epoca la Als association aveva comunicato di aver ricevuto, tra il 29 luglio al 18 agosto 2014, ben 15,6 milioni di dollari in donazioni, rispetto ai 1,8 milioni di dollari nello stesso periodo dell’anno precedente. La stessa cosa è successa ad altre associazioni che operano nello stesso campo nei Paesi dove la challenge si è diffusa, sensibilizzando l’opinione pubblica sul tema.
La Motor neurone disease association – l’equivalente britannico della Als association – dal 22 al 29 agosto 2014 ha ricevuto 2,7 milioni di sterline, mentre prima dell’arrivo dell’Ice bucket challenge riceveva in media 200 mila sterline a settimana in donazioni. In Italia, l’Associazione italiana sclerosi laterale amiotrofica (Aisla) ha riferito che grazie alla campagna Ice bucket challenge «migliaia di italiani hanno partecipato all’iniziativa donando un totale di 2 milioni e 400mila euro» che sono stati utilizzati «per finanziare la ricerca sulla Sla e per supportare ed assistere le persone, circa 6.000 in tutta Italia, che ogni giorno affrontano questa malattia».
Queste nuove e ingenti risorse hanno avuto un impatto anche sui risultati della ricerca scientifica. I ricercatori, ha comunicato l’Als association, hanno utilizzato i finanziamenti per nuovi studi clinici per testare potenziali trattamenti. L’Als association ha «impegnato quasi 90 milioni di dollari in tutto il mondo in finanziamenti per la ricerca tra il 2014 e il 2018, inclusi 81,2 milioni di dollari in 275 borse di ricerca negli Stati Uniti e altri 8,5 milioni di dollari a livello internazionale. La Als ha anche utilizzato i soldi dell’Ice bucket challenge per investire in più ricercatori, ampliando la rete di scienziati che lavorano per sviluppare trattamenti e una cura. Dal 2014 al 2018, l’Associazione ALS ha assegnato 322 sovvenzioni a 237 diversi scienziati per la ricerca sulla Sla». Hemali Phatnani, direttore del Center for Genomics of Neurodegenerative Disease presso il New York Genome Center, ha dichiarato che «l’Ice bucket challenge è stato fondamentale nel campo della genomica della Sla. Abbiamo costruito una delle più grandi risorse di dati di sequenziamento dell’intero genoma della Sla. Questa risorsa è stata condivisa con partner in tutto il mondo. Ha accelerato il ritmo della scoperta del gene della Sla e ha portato al più grande studio di sequenziamento della Sla negli Stati Uniti».
Nel 2016, infatti, grazie alle risorse ottenute attraverso l’Ice bucket challenge, è stato possibile finanziare un’importante scoperta scientifica legata alla Sla: gli scienziati hanno identificato un nuovo gene (Nek1), considerato tra i più comuni tra quelli che contribuiscono alla sclerosi laterale amiotrofica familiare. La ricerca, pubblicata su Nature Genetics, è stata definita dai media come il più grande studio mai realizzato sulla Sla ereditaria. L’identificazione del gene Nek1 ha significato una possibilità per gli scienziati per sviluppare una terapia genica per una cura. «La collaborazione globale tra scienziati, che è stata davvero resa possibile dalle donazioni di Als Ice bucket challenge, ha portato a questa importante scoperta», ha affermato John Landers della University of Massachusetts Medical School che, insieme Jan Veldink dell’University Medical Center di Utrecht, ha condotto uno studio che ha coinvolto più di 80 ricercatori in undici Paesi.
Dunque, in conclusione, l’Ice bucket challenge nata come una tendenza dei social network si è trasformata nel passo avanti decisivo verso la comprensione di una delle malattie rare più enigmatiche in circolazione. Il risultato è qualcosa di estremamente reale, che ha attraversato il mondo online, oltrepassato i confini dei social network per arrivare nelle nostre vite. Questa volta, in modo positivo.