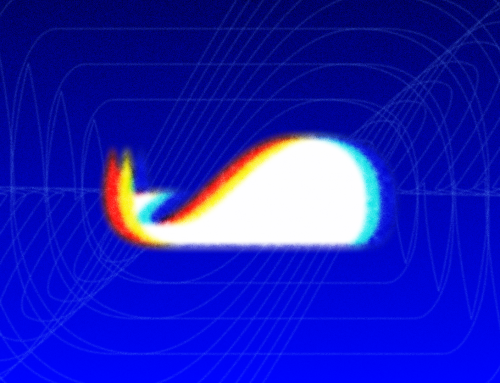Puoi anche contattare l’associazione Samaritans allo 06 77208977, tutti i giorni dalle ore 13 alle ore 22.
Come ne parlano i media
All’inizio del 2021 una bambina di dieci anni è deceduta presso l’ospedale “Di Cristina” di Palermo, dove era arrivata in gravissime condizioni a causa di un arresto cardiocircolatorio dovuto ad asfissia prolungata. Nel raccontare la tragica notizia i media, sulla base di quanto dichiarato dai parenti della vittima, si sono concentrati su una presunta «sfida estrema» terminata in tragedia e, stando a quanto riportato, diffusa su social network come TikTok. “Morire su Tik Tok”, “TikTok, Blackout challenge choc: morte cerebrale per bimba di 10 anni”, “«Sfida estrema sui social»: bimba di 10 anni muore soffocata”, erano alcuni dei titoli delle principali testate italiane in quei giorni. Questo mentre gli investigatori avevano aperto un’inchiesta per istigazione al suicidio, vagliando più piste investigative.
Facta aveva deciso di indagare meglio la vicenda e provato a verificare se effettivamente il gioco dello strangolamento o Blackout challenge – questo uno dei nomi della sfida in questione – stava spopolando sui social network (e in particolare su TikTok). Avevamo scoperto che quella dei giochi finalizzati all’auto-strangolamento è un fenomeno reale, diffuso da almeno 25 anni e precedente all’avvento dei social network.
Secondo un articolo del settimanale statunitense Time del 2018, le istruzioni di questo “gioco” erano in origine diffuse tramite il passaparola e «il gioco veniva eseguito in coppia o in gruppo, con una persona che bloccava l’afflusso d’aria ma si fermava appena prima del punto di non ritorno». Oggi, con l’arrivo di internet e dei social network, «con milioni di video dimostrativi sull’asfissia, i bambini hanno maggiori probabilità di giocare da soli a questo gioco, soffocandosi nella loro camera da letto con le loro cinture e i lacci delle scarpe».
L’indagine pubblicata su Facta non aveva rintracciato alcun video di soffocamento tra i risultati delle ricerche su TikTok, Facebook e Instagram per parole chiave come «blackout», «choking game», «soffocamento» e altri termini associati al presunto “gioco”. Diversi erano invece stati i risultati restituiti da una ricerca su YouTube, ma tutti riferiti a video che trattavano in modo critico il fenomeno, sottolineandone rischi e pericolosità. Fino al momento della notizia della tragica morte della bambina, non sembrava dunque esistere in Italia un trend diffuso del fenomeno. D’altra parte, diverse settimane dopo la notizia, i media avevano riportato gli ultimi sviluppi delle indagini: gli inquirenti, dopo aver avuto accesso al cellulare della vittima, non avevano trovato tracce di inviti a partecipare a gare di resistenza e sfide estreme, né sui social – come TikTok – né altrove. Per questo motivo, scrivevano a quel punto i giornali, «se fosse vera l’ipotesi formulata sin dal primo momento, cioè che la vittima stesse partecipando ad una challenge estrema in rete, dalle verifiche compiute finora dagli investigatori, nessuno l’avrebbe istigata o invitata a farlo».
Pochi giorni dopo il caso della bambina di Palermo, a Bari un bambino di 9 anni è stato trovato senza vita nella sua casa. Secondo quanto riportato, di nuovo, dai mezzi d’informazione tra le varie ipotesi percorse dagli inquirenti c’era quella del «gesto di emulazione legato a sfide social». Anche in questo caso, i titoli dei giornali collegavano la morte del bambino a una challenge: “Bari, bimbo morto impiccato a 9 anni: «Un tragico gioco di emulazione»”. E ciò accadeva nonostante le dichiarazioni improntate alla cautela del procuratore del Tribunale per i minorenni di Bari, Ferruccio De Salvatore, secondo cui fino a quel momento non c’erano «elementi che colleghino questo episodio a giochi online». Secondo gli sviluppi più recenti riportati dai media a ottobre 2021, la Procura di Bari, dopo aver avuto dall’autopsia la conferma della morte per soffocamento e aver passato al setaccio tutti i dispositivi digitali presenti in casa senza trovare tracce, avrebbe presentato una rogatoria internazionale per ottenere la cronologia dei video ai quali il bambino aveva avuto accesso su Youtube e capire se alla base della sua morte potrebbe esserci «un gioco estremo online».
Come abbiamo visto la copertura mediatica degli eventi ha fin da subito collegato le tragiche vicende a presunte challenge online, anche in assenza di elementi di prova consolidati e accertati. Queste scelte narrative (che non sono tipiche del giornalismo italiano, ma succede anche all’estero) rischiano di causare degli effetti negativi, come ad esempio creare interesse su giochi o sfide potenzialmente pericolose e sconosciute da parte del grande pubblico e favorire il cosiddetto “effetto Werther” (o Copycat suicide), cioè il fenomeno di emulazione che porta ad un aumento dei suicidi dopo la notizia di un suicidio pubblicata dai media.
Il caso No Nut November
Fa poi parte delle (errate) modalità di racconto da parte dei media tradizionali di ciò che accade su Internet anche l’informazione su fenomeni che si verificano in Rete (come possono essere le challenge) limitandosi a dare notizia dell’«ultima» o «nuova» moda diventata virale tra gli adolescenti, senza un’analisi di contesto e finendo in alcuni casi per fornire informazioni fuorvianti o totalmente false.
L’ultimo esempio è quello della cosiddetta No Nut November, di cui si è parlato sia in Italia (qui, qui) che in Spagna (qui, qui) a novembre 2021. In uno degli articoli di stampa italiani la vicenda è stata raccontata in questo modo: «Si tratta di una challenge nata su Internet e che prevede che gli uomini si astengano dall’eiaculazione per tutto il mese di Novembre. E no, non vale nemmeno masturbarsi. Insomma, una tortura».
Negli stessi articoli ci si spingeva anche nel riportare opinioni mediche e si sosteneva che secondo alcuni «esperti» – non citati esplicitamente in alcun punto dell’articolo – ci sarebbero «alcuni effetti benefici fisici e psicologici tra cui maggiore lucidità mentale, autostima e controllo dei propri impulsi». Come ha spiegato Rossella Dolce – psicologa e docente all’Università di Milano-Bicocca – si tratta di informazioni infondate: «Non ci sono benefici direttamente collegati alla pratica dell’astinenza sessuale» e «dal punto di vista ormonale, il ciclo che si crea è probabilmente più negativo che positivo» che può causare «nervosismo, ansia e depressione». «Interrompere una pratica sessuale non patologica ed appagante – proseguiva Dolce – è più probabile che porti negatività e non beneficio. A lungo andare poi vengono a mancare anche gli ormoni che regolano il desiderio, estrogeni e androgeni e quindi è più difficile poi recuperare una sessualità soddisfacente e spontanea per entrambi i sessi».
La No Nut November è spesso associata al movimento nato online nel 2011 denominato NoFap, molto attivo su Reddit e che dichiara di impegnarsi per far superare alle persone «le proprie dipendenze sessuali in modo che possano guarire dalle disfunzioni sessuali indotte dal porno, migliorare le loro relazioni e, infine, vivere le loro vite in maniera più appagante». Tuttavia, come sostenuto dall’analista ed esperto di rivoluzione digitale Fiorenzo Pilla, la dipendenza dalla pornografia è «una patologia complessa […] e il trattamento del disturbo da dipendenza richiede una terapia integrata, ovvero che possa offrire uno spazio e progetto individuale, uno di gruppo e uno farmacologico»: trattamenti decisamente diversi rispetto ad una sfida social. Dunque, dal punto di vista scientifico, quanto riportato da alcune fonti stampa sembra inesatto.
Infine, oltre a risultare inutile dal punto di vista medico, questa sfida presenta anche un’ulteriore aspetto problematico: con il tempo infatti sembra essere stata cooptata da alcuni gruppi, chat e forum di misogini e estrema destra, come riportava già nel 2018 il magazine di tecnologia statunitense MotherBoard.
Vecchi e nuovi media
Come abbiamo visto, una parte rilevante degli intoppi nella corretta divulgazione delle social challenge è dovuta al cortocircuito generazionale tra vecchi e nuovi media, con i primi che spesso finiscono per fraintendere le modalità espressive dei secondi e distorcerne le finalità. Intercettare i nuovi linguaggi di Internet, del resto, non è cosa semplice, a maggior ragione per un sistema giornalistico come quello italiano. Secondo i dati del censimento degli iscritti alle forme di previdenza integrativa – cioè, in buona approssimazione, i giornalisti delle redazioni più grandi o comunque con i contratti più solidi – risalente al 2018 l’età media era pari a 58 anni.
Internet, insomma, è un mondo complesso e la mancata comprensione delle sue dinamiche – magari per mere questioni anagrafiche – può innescare un meccanismo in grado di generare disinformazione, panico morale e, nei casi più estremi, fenomeni emulativi. Il caso più eclatante, a tal proposito, è quello che riguarda “Jonathan Galindo”, che nella seconda metà del 2020 veniva descritto da quotidiani e trasmissioni televisive come il «gioco mortale» che a Napoli avrebbe spinto al suicidio un bambino di appena 11 anni, attraverso una serie di «sfide di coraggio» sfociate nell’autolesionismo. Ma come stavano davvero le cose?
La genesi di “Jonathan Galindo”
Il debutto di Galindo nelle cronache italiane è avvenuto l’8 luglio 2020, in un articolo del Resto del Carlino intitolato “Lame e sangue, l’ultima sfida social. ‘Giovani spinti a farsi del male’”. La storia riguardava una presunta «challenge» che al tempo sarebbe stata in corso tra gli adolescenti italiani, che consisteva in una serie di sfide lanciate da un misterioso profilo Facebook chiamato “Jonathan Galindo”. La giornalista lo descriveva come un «Pippo deformato con sembianze umane ma che provocano spavento».
La dinamica della presunta sfida ricordava molto da vicino quella già incontrata nella narrazione di Blue Whale, di cui abbiamo parlato nel terzo capitolo: “Galindo” invierebbe una richiesta d’amicizia ai profili Facebook di ragazzini tra i 12 e 15 anni, per poi contattarli in privato e chiedere loro: “Vuoi giocare?”. L’eventuale risposta positiva innescherebbe un «gioco di sfide e prove di coraggio fino ad arrivare all’autolesionismo», sosteneva l’articolo del Resto del Carlino, che segnalava l’esistenza di ben quattro casi nella sola provincia di Ancona.
C’è solo un piccolo problema: “Jonathan Galindo” non esisteva. O meglio, esisteva, ma solo come racconto del terrore inventato su Internet. È ciò che nel gergo della Rete si definisce un “creepypasta”, ovvero in un breve racconto dell’orrore (creepy, raccapricciante) che viene copiato e incollato (copy and paste, da cui pasta) in diversi angoli del web, ma totalmente privo di fondamento. Racconti di questo genere nascono con il preciso intento di suscitare spavento o angoscia nel lettore e rappresentano un vero e proprio genere letterario, che ha raggiunto il suo picco di popolarità attorno al 2010 con la pubblicazione di una storia sul tema da parte del New York Times.
Uno di questi racconti, risalente agli albori di Internet, vedeva come protagonista proprio un personaggio chiamato Jonathan Galindo, descritto come un clown caduto in disgrazia e affetto da un malattia che ne ha deformato la parte superiore della bocca. A causa di questa imperfezione estetica, Galindo sceglieva di indossare il trucco che lo trasformava in un “Pippo umano” e iniziava a covare un odio crescente per i bambini che lo deridevano a causa del suo aspetto fisico. In alcune versioni della storia, Galindo avrebbe provato senza successo a lavorare nel parco divertimenti Disneyland, prima di dare il via a una scia di omicidi e infine contattando le sue vittime sulla Rete.
Com’è evidente, Jonathan Galindo è semplicemente il frutto dell’immaginazione di un utente di Internet, e tale è rimasto fino all’11 gennaio 2017, quando la versione messicana di Blasting News – un sito web d’informazione che retribuisce i suoi redattori in base alle visite generate dagli articoli – ha pubblicato una storia dedicata al «profilo Facebook di Jonathan Galindo» e alle «teorie che circondano questo strano personaggio vestito da Pippo». È qui che per la prima volta il nome di Galindo è stato associato a una specifica immagine, che in seguito si scoprirà essere un’opera dell’artista e creatore di maschere americano Samuel Canini, noto sul web anche come Dusky Sam e Sammy Catnipnik.
Per tornare in auge nel 2020, la storia di Galindo aveva bisogno solo di un ultimo ingrediente, che è puntualmente arrivato il 22 giugno, grazie ad alcune storie pubblicate dall’influencer messicano Carlos Name (1,7 milioni di follower su Instagram al momento della pubblicazione) in cui affermava di aver avvistato il “Pippo umano” dalla finestra della sua abitazione. Si trattava, anche in quel caso, di un contenuto di finzione, ma divenuto virale al punto da stimolare la creazione di numerosi profili su TikTok nati per impersonare Jonathan Galindo.
Alla data del 3 dicembre 2021, nessun caso di violenza – inflitta o autoinflitta – è stato ufficialmente collegato alla social challenge “Jonathan Galindo”.
I linguaggi di Internet
L’incomunicabilità tra vecchi e nuovi media ha generato mostri immaginari come Jonathan Galindo, ma in passato la stessa dinamica ha riguardato altre leggende metropolitane, prive di fondamento ma comunque arrivate sui mezzi di comunicazione tradizionali.
È il caso della cosiddetta “Momo Challenge”, che tra il 2018 e il 2019 arrivò sui siti d’informazione italiani come pericolosa sfida innescata da una catena di messaggi WhatsApp e in grado di provocare il suicidio di una ragazza argentina, ma in realtà totalmente priva di fondamento. O della Samara Challenge, un gioco piuttosto innocuo che consisteva nello spaventare i passanti travestendosi come la protagonista del film horror The Ring, che nella narrazione mediatica è stato ampiamente sovradimensionato al punto da generare una denuncia del Codacons. O, ancora, del presunto “giochino del semaforo rosso”, comparso per la prima volta in un articolo del Messaggero dedicato alla morte delle sedicenni romane Camilla Romagnoli e Gaia Von Freymann e descritto come una sfida ad «attraversare le due carreggiate di Corso Francia veloci mentre per i pedoni è rosso e per le auto che sfrecciano è verde, sfidando la sorte», filmare e pubblicare tutto sui social. Anche in questo caso la notizia si è rivelata infondata e smentita dall’evoluzione delle indagini.
Ma perché alcune dinamiche di Internet risultano incomprensibili agli occhi del giornalismo italiano? Lo abbiamo chiesto a Sofia Lincos, caporedattrice di Query Online ed esperta di leggende metropolitane:
Dunque, il giornalismo tradizionale e Internet parlano talvolta lingue molto diverse e si tratta di linguaggi radicalmente differenti e per certi versi incompatibili, che si rivolgono a platee eterogenee con intenti opposti. Nella sua ormai trentennale evoluzione, la Rete ha sviluppato un modello di scambio delle informazioni fondato sulla collaborazione e sulla gratuità, incarnato alla meglio da Wikipedia e da Creative Commons – la licenza che consente di condividere gratuitamente (e legalmente) una vasta gamma di opere – ma soprattutto dagli sforzi profusi da personaggi come l’attivista informatico Richard Stallman nella la ricerca di un modello alternativo al copyright.
Questo particolare approccio alla condivisione è ancora oggi vivo e vegeto su forum e piattaforme di social network, e ha contribuito in modo decisivo alla nascita e allo sviluppo di linguaggi peculiari in grado di affermarsi sul web. Linguaggi come i creepypasta, appunto, racconti di fantasia prodotti dal basso e condivisi gratuitamente in apposite comunità, o come i meme, una forma di comunicazione (fatta per lo più di immagini) che sfrutta la condivisione degli utenti e le loro personali reinterpretazioni per puntare alla viralità.
Non è un caso che la comprensione di questi nuovi linguaggi risulti particolarmente ostica al giornalismo mainstream, professione che ha un modello di business in larga parte centrato sulla capacità di monetizzare i contenuti e, allo stesso tempo, possiede una serie di regole deontologiche codificate. Regole che sono spesso e volentieri disattese: scopriamo quali sono.
Perché ci sono delle regole per i media
Come dovrebbero comportarsi giornalisti ed esperti dei media quando si trovano a raccontare, in generale, delle vicende delicate, a rischio emulazione o che riguardano direttamente dei casi di suicidio? Le regole esistono, e sono molto chiare anche a livello internazionale.
Nel 2008 l’Organizzazione mondiale della sanità (Oms) ha pubblicato il documento intitolato “La prevenzione del suicidio: suggerimenti per i professionisti dei media” in cui delineava una serie di linee guida da seguire per affrontare temi più o meno vicini al suicidio. Il documento – aggiornato nel 2017 – passava in rassegna obblighi e doveri del giornalista, fornendo consigli utili e mettendo in guardia dai principali pericoli legati ad una narrazione sensazionalistica o disattenta.
Prima di passare in rassegna le principali regole da seguire e i pericoli da cui stare in guardia, cerchiamo di capire perché il linguaggio dei media in queste occasioni è così importante.
Nel 2017 l’Oms ha calcolato che annualmente sono circa 800.000 i suicidi al mondo e che almeno sei persone possono essere condizionate da un singolo caso: i media giocano un ruolo chiave in grado di «potenziare o indebolire» gli sforzi di prevenzione. Dello stesso parere anche diversi studi che hanno sottolineato come la narrazione di un suicido (o, più in generale, di un evento drammatico) possa di per sé diventare fonte di ispirazione o di emulazione per le persone a cui è destinata, e che è per questo importante investire su un giornalismo in grado di informare correttamente il pubblico e di scongiurare, grazie alle tecniche narrative messe in atto, eventi dello stesso tipo.
L’influenza dei media sui comportamenti delle persone – e, in particolare, sui suicidi – non è un fenomeno recente e, come si potrebbe erroneamente pensare, imputabile alla presenza che hanno oggi Internet o i social network. Si tratta in realtà di una storia precedente e che riguarda i media nel loro insieme. Risale infatti al 1974 il primo studio retrospettivo che ha dimostrato l’impatto negativo dei giornali inglesi e americani sul fenomeno, mettendo in luce come maggiore era la pubblicità dedicata a una storia di suicidio da parte della stampa, maggiore era l’aumento dei successivi suicidi.
Non solo: effetti imitativi negativi sono stati riscontrati anche in uno studio del 1988 che prendeva in esame l’aumento dei suicidi in seguito alla messa in onda di alcune serie televisive. Stessi risultati sono stati ottenuti prendendo in esame le trasmissioni televisive e i notiziari in particolare. Dunque, in passato così come oggi, il problema non riguarda Internet ma in generale il mondo dell’informazione, senza distinzione tra vecchi o nuovi media. Oggi i media digitali sono una preziosa risorsa per coloro che hanno bisogno d’aiuto, vista la facilità con cui è possibile accedere ad informazioni e contatti utili, ma Internet rimane anche un luogo in alcuni casi pericoloso: la facilità con cui è possibile accedere ad immagini e metodi di suicidio e la quantità di canali di comunicazione che possono essere utilizzati per bullismo o molestie sono motivo di preoccupazione, soprattutto per i più giovani.
Ragionando poi sulla nostra quotidianità, non possiamo escludere i pericoli presenti sui social network e, tra questi, anche le challenge negative o, come abbiamo visto, “mal interpretate” da parte del mondo dell’informazione. E in questi casi, che cosa succede? Quando l’errata narrazione dei media fa sì che i “giochi” del web diventano più pericolosi di quanto non lo siano realmente? Lasciamo nuovamente la parola a Sofia Lincos.
Ricollegandoci proprio a quanto detto da Lincos, andiamo a scoprire nel dettaglio quali sono le linee guida internazionali fornite dall’Organizzazione mondiale della sanità.
Parlare di suicidi: rischi e benefici della narrazione giornalistica
Come abbiamo visto, la narrazione giornalistica può essere pericolosa quando si parla di suicidi. Il rischio principale è che un suicidio venga narrato con una tale ricchezza di dettagli e pathos da colpire delle categorie di pubblico già particolarmente vulnerabili (e che spesso contano al loro interno numerosi giovani): stiamo ad esempio parlando di persone che soffrono di malattie mentali, di persone con una storia di comportamento suicidario alle spalle o che hanno vissuto un lutto per suicidio. Queste persone – che fanno parte del pubblico a cui un racconto giornalistico è destinato – rischiano di immedesimarsi nella vittima: ciò accade quando le caratteristiche del suicida sono in qualche modo simili a quelle del lettore/spettatore, che si identifica in prima persona nella narrazione si lascia trasportare da essa.
Che cosa non va fatto dunque per evitare queste conseguenze negative? Scopriamolo insieme.
Al primo posto tra le cose da evitare secondo l’Oms c’è il dare un’eccessiva visibilità alla vicenda: i giornali dovrebbero posizionare le notizie di suicidi nella parte inferiore delle pagine interne, piuttosto che in prima pagina o nella parte superiore delle successive. Regole simili anche per gli altri media: in seconda o terza posizione per i servizi televisivi, in coda ai servizi radiofonici o agli aggiornamenti di notizie diffusi sui social network. È poi da evitare un linguaggio sensazionalistico (sì ad espressioni come «crescita del tasso di suicidi», no a quelle come «pandemia di suicidi») o argomentazioni che normalizzano il suicidio; o, ancora, «suicidio fallito» o «riuscito» sono espressioni da evitare perchè implicano che il suicidio sia qualcosa di desiderabile.
Altro aspetto su cui bisogna porre particolare attenzione sono i titoli, cercando di limitare quanto più possibile espressioni che possono risultare fuorvianti. Non va poi mai esplicitamente descritto il metodo utilizzato dalla vittima per suicidarsi, né vanno dati dettagli sul luogo del decesso. Dal punto di vista dei contenuti multimediali, non bisogna utilizzare immagini, video o link (per le notizie pubblicate online) che mostrano la vittima o il luogo in cui è avvenuto il suicidio: diversi studi dimostrano come i contenuti visuali possono colpire in maniera negativa il pubblico più vulnerabile. Lettere, sms o altri contenuti lasciati dalla vittima non devono mai essere pubblicati. Infine, le narrazioni che ripetono falsi miti sul suicidio finendo per diffondere disinformazione arrecano danno tanto al pubblico, quanto al giornalismo stesso. Ma di che falsi miti si tratta? Ve lo spieghiamo qui sotto.
Miti sui suicidi
È importante notare che le storie di suicidi raccontate dai media nel rispetto delle regole che abbiamo ricordato più sopra hanno un forte impatto preventivo. Al primo posto tra i consigli utili e le regole deontologiche da rispettare secondo l’Oms c’è fornire chiare e aggiornate informazioni sui centri di prevenzione e aiuto, riportando recapiti e modalità di contatto e prediligendo le realtà riconosciute a livello nazionale e attive 24 ore su 24.
È poi importante non condividere falsi miti o credenze, e prediligere storie che hanno come protagonisti persone che si sono riscattate o che sono riuscite a reagire positivamente alle circostanze avverse. Ma non solo: va prestata particolare attenzione quando si raccontano i suicidi di celebrità o personaggi pubblici, dal momento che spesso sono dei modelli di riferimento per lo stile di vita. In questo casi l’Oms suggerisce di concentrare la narrazione sulla vita della celebrità, su come ha contribuito positivamente alla società e su come la sua morte influisca negativamente sugli altri.
Infine, sono fondamentali le scelte che si fanno quando si decide di coinvolgere familiari o amici della vittima, poiché possono ricoprire un ruolo chiave nella prevenzione ma sono al tempo stesso persone spesso colte in un momento di fragilità e dolore. D’altra parte, non bisogna dimenticare che anche chi racconta la storia potrebbe essere una persona vulnerabile e bisognosa d’aiuto.